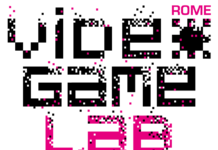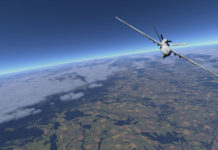La gamification è una pratica nella sua fase embrionale. Infatti, molti di coloro che se ne occupano usano una terminologia fuorviante e confondono gioco e gara, oppure gioco e trastullo. Il motivo è che la progettazione ludica in ambito professionale è ancora in larga parte nelle mani di appassionati di giochi invece che di esperti progettisti.
La parola Gamification sta conoscendo un periodo di grande notorietà in ambito professionale. Se ne parla in relazione a iniziative di marketing, di formazione, di addestramento, di selezione del personale, di introduzione dei neoassunti (corporate induction), ecc. La usano molti dei fornitori di servizi alle aziende: agenzie di consulenza, di marketing e comunicazione, di formazione.
Fino ad oggi c’è stata una grande confusione. Non è ben chiaro cosa la gamification sia, ma, come spesso accade quando una parola diviene di moda in azienda, molti la usano cercando di intuirne il significato o di piegarlo all’esigenza di vendere “roba vecchia in una nuova confezione”.
La causa più importante di tale confusione risale al giudizio morale sulla natura dell’ambito di cui stiamo parlando. Il gioco, che non sia quello d’azzardo, viene spesso considerato una attività prevalentemente infantile o, meglio, puerile. L’aggettivo “infantile” ha anche un’accezione deteriore, che lo contrappone a “serio” (come si vedrà chiaramente quando parlerò di serious games), onde chi si occupasse professionalmente di gioco si occuperebbe perciò di cose puerili, ovvero non serie.
Questo pregiudizio induce spesso gli operatori professionali meno avveduti a costruire astruse terminologie alternative, atte a paludare le proprie presentazioni aziendali. Così, per esempio, in un’aula di formazione non si gioca, bensì “si somministrano dei games”. In tal modo, oltre a coprirsi di ridicolo, si è introdotta nella mente degli interlocutori aziendali l’idea che “game” sia accettabile, a differenza di “play”, al quale viene erroneamente lasciato l’ufficio di tradurre il concetto di “gioco infantile”, “intrattenimento puerile” o altro sinonimo del vernacolo romanesco, volgare quanto efficace.
Questo pregiudizio non è una prerogativa italiana. Infatti, nei paesi anglosassoni si è ritenuto problematico ricorrere a un aggettivo come “playful” per caratterizzare un’attività professionale o un modo di apprendimento. Il Cambridge Dictionary definisce l’aggettivo in questo modo: “funny and notserious”; Oxford, Collins e Merriam Webster sono meno dispregiativi, ma non si allontanano troppo da questa definizione.
Che la difficoltà fosse confermata dal vocabolario è testimoniato dal conio di una parola ad hoc: “gameful”. Questo aggettivo per Collins, Cambridge e Merriam Webster semplicemente non esiste. Quelli dell’Oxford Dictionary sono stati più tenaci è hanno recuperato un significato dimenticato da secoli: “Originally: “affording much enjoyment to hunters (obsolete). In later use: abounding in game. Now rare.”
Mi soffermo su questo dettaglio linguistico perché si tratta di un caso di serendipità: i redattori, cercando disciplinatamente di evitare un ennesimo insopportabile neologismo, hanno involontariamente centrato un aspetto cruciale della gami(sti)fication: l’impropria identificazione tra il concetto di gioco e quello di gara.
Le parole inglesi “game” e “play” hanno campi semantici molto ampi, il che ha incrementato il caos terminologico e mentale di molti dilettanteschi operatori della gamification. L’intraducibile espressione “to play a game” distingue acutamente l’atto e l’atteggiamento del giocare dal gioco inteso come sistema di regole che disciplinano l’interazione con e tra i giocatori. Tuttavia, “game” ha anche un’accezione fortemente connotata in senso competitivo: per chiedere a qualcuno se è pronto a correre un rischio, ad affrontare un sfida, un inglese può chiedere: “Are you game?”
Ora, può sembrare rischioso proporre in azienda una cosa che può suscitare nella mente di un manager la dimensione del divertimento puerile, che pare relegata a “gioco” e “play”. Al contrario, quella della competizione, magari di quella virile, caratteristica dell’esercizio della caccia fortuitamente riesumata dai lessicografi oxoniensi, tocca una corda ben più facile da far vibrare in azienda. Per un profano, elementi costitutivi del gioco sono quindi il punteggio, la classifica e il premio da assegnare al vincitore. Secondo questa visione, per gamificare(sic!) qualunque attività sarebbe sufficiente appiccicarle una o più classifiche: ed ecco che la gamification si riduce alla ben più triste “tokenification”. Il bello è che questa sindrome è conosciuta dagli anni settanta, quando gli studiosi americani, in riferimento agli educational concepiti secondo questo criterio, parlavano di chocolate covered cabbages, cioè a dire: per farti imparare le tabelline (o le procedure) giocando, faccio una gara a chi risponde per primo e al vincitore do una bella coccarda da secchione, con su scritto: “Sono il #1 delle tabelline (o delle procedure)!”.
Per esempio, in un quotato sito italiano sull’argomento si legge: “Possiamo definire la Gamification come un insieme di regole mutuate dal mondo dei videogiochi” e già proprio non si comprende perché ci si debba limitare al sottoinsieme dei videogiochi; ma andiamo avanti: “…il processo di communication design deve necessariamente essere ripensato in modo da introdurre meccaniche e dinamiche di gioco, aggiungendo ai fattori tradizionali altre componenti trainanti (ancora, mutuate dal mondo del “gaming”) (…) Le meccaniche e le dinamiche di gioco rappresentano i veri “ferri del mestiere” nell’ambito della Gamification, necessari “gamificare” un sito o un servizio: l’introduzione di concetti come punti, livelli, missioni e sfide incoraggia gli utenti ad investire il proprio tempo, spingendoli alla partecipazione e aiutandoli a costruire delle relazioni all’interno del gioco”. Ecco teorizzato il convincimento che la dimensione ludica possa ridursi a quella competitiva, un assunto la falsità del quale è stata teorizzata fin dai tempi di Roger Caillois.
È interessante notare che chi la vede in questo modo, come si può leggere nelle pagine dello steso sito, parla di “games” identificandoli con un particolare sottoinsieme dei videogames che include i First Person Shooter e l’evoluzione tridimensionale dei Platform, ma, per esempio, esclude le Graphic adventure on Minecraft (l’evoluzione digitale del LEGO) e tutti i giochi in cui combattimento, competizione, raccolta e livelli siano poco rilevanti o addirittura completamente assenti.
Un altro specialista della comunicazione,prestato al mondo professionale del gioco,scrive nel sito di un importante editore: “I Punti sono il primo semplice elemento che permette di stimolare la partecipazione e motivare le persone. La Ricompensa può essere anche virtuale, ma deve rendere l’idea di guadagnare qualcosa”. È sorprendente l’ingenuità con cui si può sostenere che “i punti stimolano la partecipazione”, mentre è evidente che essi semplicemente ne misurano l’esito.
Al contrario, si stanno diffondendo sempre di più molti giochi cooperativi, non necessariamente digitali, che sono potenzialmente interessantissimi per l’uso in ambito professionale, dove il tema della capacità di collaborazione è oggetto di interesse sempre più acuto.
In ambito accademico, per essere certi che all’esterno non si immaginasse un gruppo di ricercatori buontemponi che passano il loro tempo tirandosi i pennarelli, assai prima che “gamification” fosse coniato si fece una scelta esplicita: nel lontano 1970, Clark C. Abt inventò l’espressione “serious games”. Dai primi anni duemila e fino a pochi anni fa, quello che oggi è il MIT GAME LAB, fu intitolato appunto ai Serious games studies. Paradossalmente, nell’ambito della pubblicità e della comunicazione assistiamo a un fenomeno diametralmente opposto. Qui la dimensione dell’intrattenimento è fondamentale e quindi “playful” è bene accetto. Così abbiamo assistito al successo planetario del cosiddetto “funfactor”: per chi non lo conoscesse basti immaginare un’uscita della metropolitana. La scala accanto a quella mobile viene trasformata nella tastiera di un pianoforte: ogni gradino diviene un tasto azionato dal peso dei passanti. “Miracolosamente”, molti smettono di usare la scala mobile e riprendono la salutare abitudine di fare le scale a piedi, tutto grazie, appunto, al “funfactor”. Ebbene, anche questo sarebbe un esempio classico di “gamification”. Tuttavia, è bene osservare che il tipo di attività ludica rappresentata da un simile esempio è esattamente la stessa che governa l’interazione tra un neonato e il suo sonaglino: la coazione a ripetere è determinata dal piacere funzionale, che a quell’età scatta anche nel fare esperienza dei propri piedi. Tuttavia, come ogni buon pedagogo sa, il piacere di questa modalità ludica scema rapidamente col passare dei mesi: un quindicenne, per tacere di un adulto, fa fatica a giocare con i propri arti, che ormai non lo sorprendono più molto. Allo stesso modo, la scala sonante sorprende perché è inaspettata: funziona perché molti dei passanti di una uscita della metropolitana non sono ancora passati di là, ma che succederebbe se si installasse un simile impianto in un ufficio? Dopo quanto tempo quel trastullo si ridurrebbe semplicemente a un fastidio?
Riassumendo: molta parte della gamification fino ad oggi si è ridotta a un appiccicare elementi accessori della competizione a una meccanica ripetitiva e noiosa, oppure presentare una meccanica banale ma sorprendente perché straniante o fuori contesto.
Credo sia ormai chiaro che il limite della gamification 1.0 è proprio nella banalizzazione delle meccaniche. Si cerca di emulare una situazione ludica avendo mantenuto solo i suoi aspetti esteriori: è come se qualcuno cercasse di farvi vivere l’esperienza del giocare a TABOO® facendovi domande sull’antiriciclaggio e dandovi il celebre buzzer per prenotarvi a rispondere per primi, oppure vi installasse a sorpresa il relativo file audio al posto di quello che tradizionalmente si sente quando ricevete una e-mail: la prima volta ne ridete (funfactor); alla decima non ci fate più caso; alla centesima chiedete un suono meno fastidioso.
Una riprova di quanto qui affermo si può avere osservando uno schema assai spesso riprodotto sui siti italiani tratto dal blog di Andrzej Marczewski:
L’assassino è la scomparsa del gameplay, cioè dell’unico vero componente essenziale di un videogame (il cui corrispondente in un gioco da tavolo è l’interazione regolata con i componenti o tra giocatori) che regola la dinamica dell’interazione tra giocatori e sistema e tra giocatori.
Il motivo della scomparsa è molto semplice: progettare un gioco interessante per chi non abbia più la struttura psicologica e le capacità di un neonato, che quindi possa anche mappare efficacemente una dinamica complessa, come può essere quella di un tipico fenomeno aziendale, richiede un’esperienza e competenze professionali specifiche che molti degli attuali improvvisati operatori, in quanto giocatori (magari professionisti) e non autori di giochi, non possiedono. Non a caso la biografia di Andrzej Marczewski si apre nel modo seguente: “My true passion has always been gaming – and guitar, but gaming mostly! I was introduced to video games very young as my Dad was a fan (with is [sic!] Apple II and our Acetronic MTU 1000!). This eventually lead me to starting Yet Another Review Site as a way to talk about games, review them and encourage others to do the same”. Per progettare un’automobile non basta essere un appassionato di Formula 1: non si vede perché il caso dei giochi dovrebbe essere diverso. Il mondo della gamification uscirà dall’attuale fase embrionale quando i veri autori di giochi da tavolo e videogame designer inizieranno a occuparsene con convinzione, superando la repulsione suscitata dalla attuali rozze semplificazioni.